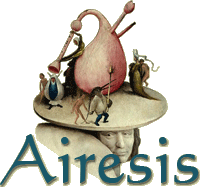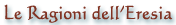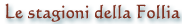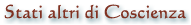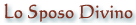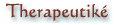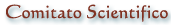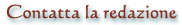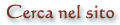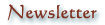Tra scienza e fede
La "crisi" dei valori e il valore della speranza
Paolo Aldo Rossi - Ordinario di Storia del Pensiero Scientifico, Università di Genova
L'illuminismo, nel senso più ampio di pensiero in continuo progresso, ha perseguito da sempre l'obbiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni. Ma la terra interamente illuminata splende all'insegna di trionfale sventura [â¦] Ma i miti che cadono sotto i colpi dellâilluminismo erano già il prodotto dellâilluminismo stesso.Â
M. Horkheimer e T. W. Adorno, Dialettica dellâIlluminismo, Einaudi, pp. 11 e 16.
La fede è quindi il fondamento sostanziale (o il costrutto sostanziale) di quello che si spera e prova di quelle cose che non si vedono. Per mezzo di questa fede gli antichi ricevettero buona testimonianza. Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sì che da cose non visibili ha preso origine quello che si vede.[1]
Lettera agli Ebrei 11-1-3
Vorrei mettere a confronto questi due testi, passandoli attraverso lâEnciclica Spe Salvi, cercando di meditare e di ponderare il fatto che un Sommo Pontefice, Benedetto XVI, ossia Joseph Ratzinger, uno dei maggiori teologi dei nostri tempi, li abbia citati nelle stesse pagine: cioè una delle più belle lettere âcattolicheâ del Nuovo Testamento e un libro, scritto 19 secoli dopo, che ha segnato la nostra gioventù in aperta, onesta e leale, ma âoscurataâ contestazione (in altre parole lâAufklärung che diventa il suo contrario).
Ormai non più âparalizzati dalla paura della verità â, forse perché il tempo ci ha abituati a guarire le ferite facendone altre sempre più profonde ed abdicato alla voglia di dominio della natura, oltretutto partendo dai fatti, cosa che abbiamo assimilato quando abbiamo compreso che la scienza non si occupa di dati irremovibili, ma di problemi ininterrotti e incessanti, abbiamo percorso, da viandanti sperduti, la strada che porta dallâestetico allâestatico, di solito senza mai raggiungerlo, ma passando per lâhypostasi sperata, prova di quello che non cade sotto i nostri sensi, ma che ci attendiamo che esista per dare un senso alla nostra vita.
Dopo essere passati attraverso lâilluminismo, ossia lâimpegno ad usare la critica e la guida della ragione in tutti gli ambiti dellâesperienza umana, il sapere aude! guidati solo dal proprio intelletto, ci siamo trovati nei panni del â⦠pensatore odierno a cui si chiede niente di meno che questo di essere nelle cose e fuori dalle cose; è il gesto del barone di Münchausen che si solleva dallo stagno afferrandosi per il codino"[2]. E il portare la ragione di fronte al tribunale della ragione ci è sembrato alla fine più un conflitto dâinteresse che un aforisma ben costruito e lâEmpirismo, paredro dellâAufklärung, si accorge che se uno cerca di arrivare molto vicino all'arcobaleno questo scompare come la conoscenza umana lasciata esclusivamente ai sensi e allâesperienza.
Paesaggio con arcobaleno - P.P. Rubens, 1642-1645
Il senso comune
Nell'antica lingua greca, costituitasi storicamente come la portatrice privileÂgiata del bagaglio concettuale di quel particolare impianto razionale che è la âfiloÂsofiaâ, il termine "crisi" significa "giudico al fine di compiere una scelta" ed ancora "spiego, interpreto, risolvo, decido". In questo senso la "crisi dell'uomo" si propone come il momento più tipico ed essenziale del suo essere nel mondo: quello in cui egli, non contento del semÂplice referto dei sensi, va alla ricerca del fondamento e travalica l'empirico per apÂprodare alla conoscenza, la quale è solo una delle successive tappe di un camÂmino che ancora deve percorrere gli stadi dell'interpretazione (il conferimento di senso e di valore) e della decisione in merito all'azione (la conclusione dell'inferenza praÂtica che ha come premessa maggiore il risultato della conoscenza e come concluÂsione le indicazioni, da questa ricavate, in relazione all'agire). In questo senso lo stato di crisi rappresenta l'autenticità che si oppone all'alienazione, il riconoscimento del dubbio come fonte del sapere, la consapeÂvolezza che il rischio della scelta è anche la condizione basilare della libertà .
Il termine aristotelico κοινὴ αἴÏÏηÏÎ¹Ï (senso comune[3]) denota due diverse funzioni metasensibili:
a) la consapevolezza della sensazione;
b) la percezione delle determinazioni sensibili comuni ai diversi sensi.
Eâ naturale pensare alla prima come ad una sunaistesis (ciò che accompagna una percezione sensoriale o la consapevolezza di sentire), dove lo âsperimentare di sentireâ è sempre mediato in un linguaggio che lo esprime, ossia âun dialogo interno dellâanima con se stessaâ[4] contrapposto al fluire delle informazioni che lâanima subisce dai sensi[5].
Il secondo è la percezione del movimento, della quiete, della grandezza, del numero, dellâunità ... ossia di quelle qualità comuni a più sensi che proprio perciò non appartengono ad un senso particolare.
Lâaistesis koiné rappresenta, quindi, il saldo ancoraggio teoretico allâempirico necessario allâepisteme, affinché i suoi contenuti possano divenire oggetto di comunicazione e quindi intersoggettivabili.
Mentre la via verso lâestetico è comune ai vari uomini (nei suoi diversi gradi), la via verso lâestatico (solo di pochi uomini e in situazioni molto particolari) è lâunico modo per liberare il sovrappiù di conoscenza dallâazione inibitrice dei sensi e permettere, così, la trasformazione dellâintelligenza in un âexcessus mentisâ. E qui â usando tale termine - non sto citando San Bernardo (cosa che ci prenderebbe molto tempo, per non essere poi capaci di definirla), ma il mettere a confronto âil ciò che sta saldo sopra un sostegno di baseâ con âquello che si sposta continuamente da qualsiasi appoggioâ.
   Con lâepisteme (ejpivsthvmi, scienza intesa come conoscenza realizzata nella sintesi fra il logico e lâempirico) si raggiunge âil ciò che sta saldo sopra a una base inamovibileâ, mentre lâuomo, quando non è più padrone dei propri sensi, si sposta âda ciò che sta saldoâ, ossia dalla teoria della conoscenza, e ricorre all'insieme delle "visioni" prodotte dall'anima e icastiche della divinità e del sacro, che però non possono nemmeno essere proferite e ascoltate, ma solo intuite e di-svelate. Il termine estasi[6] (da ejxivsthmi), ripetiamolo ancora, indica lâazione del dislocare o meglio indica lâuscire fuori da ciò che sta saldo, ossia dallâepisteme (la conoscenza costituita sul fondamento). "Spostarsi da ciò che sta sul fondamentoâ vuole dire inoltrasi (andar oltre) e percorre la strada della conoscenza mistica.
Ma per tutti gli uomini resta sempre aperta la via dellâ ujf ivsthmi o dellâupo isteme ciò che sta sotto [a tutto] e che lo regge, lâhypostasi o la realtà che fa da principio a tutti i percorsi umani. Noi uomini iniziamo sempre con un sogno meraviglioso, il mito (da bambini o da poeti), per poi svegliarci (di colpo o a poco a poco) in un mondo fatto di eventi che si numerano, si contrassegnano, si spiegano e che servono o a prevedere da quel che è accaduto e spiegato oppure a volerlo solo conoscere. Però a volte alcuni di noi abbandonano questo mondo per addentrarsi in ciò âche sta oltreâ, mentre tutti abbiamo a che vedere con lâhypostasi, il fondamento di quello che ci si aspetta e accerta di quelle cose che non si vedono. Lo strumento conoscitivo che può mettere lâuomo a contatto con le modalità del manifestarsi del divino non appartiene alla sfera dellâempirico, ma sta oltre, deborda dai limiti dei sensi, mentre lâhypostasi fa parte della sfera in cui ogni uomo vive, non ha una struttura scientifica né unâossatura mistica, ma si rivolge alla speranza per farlo vivere ed è ciò a cui noi diamo il nostro consenso, la nostra adesione, la nostra fiducia, il nostro ideale, la nostra religiosità , le nostre argomentazioni ⦠Il nostro assentimento a tutto questo (alla fede, alla credenza, alla convinzione â¦) deriva dal fatto che â nella speranza siamo stati salvatiâ ( Rm 8, 24) e non solo i credenti, ma tutti quelli che hanno creduto che quello che a noi appariva come realtà era la nostra autentica visione della mondo, che come uomini dovevamo avere e non solo ânei limiti della ragioneâ, resa anticipatamente limitata e confinata dalla esperienza. Dai tempi di Esiodo allâuomo non era rimasta che solo la Speranza e Platone dichiara che il Caos era come un qualcosa che nessuna divinità abita, mentre Paolo di Tarso dichiara che senza il Cristo si è âsenza speranza e senza Dio nel mondo » (Ef . 2,12).
La meraviglia e il dubbio
Fin dalle origini del pensiero occidentale ritroviamo la convinzione che la meraviglia sia la scaturigine unica ed insostituibile di quel particolare modo d'essere dell'uomo nel mondo che è il suo tendere verso la conoscenza. L'iridescenza proteiforme del cosmo indifferenziato, i fenomeni cangianti, le apparizioni e le sparizioni, le metamorfosi degli oggetti provocano nell'uomo che li vive lo stupore ammirato: il Thaumazein. Platone suggerisce a questo riguardo unâimmagine mitica di rara potenza evocativa: "Questo senso della meraviglia è la caratteristica precipua del filosofo, né la filosofia ha altro principio che questo. Chi ha mostrato che Iride è figlia di Taumante non ha errato nel tracciare la geneaologia degli dei "[7].
Ma Iride (l'arcobaleno) non è solo il più suggestivo dei fenomeni che avvengono nel cielo, è anche il simbolo dell'incessante riappacificazione degli elementi in lotta. Il suo apparire dopo la tempesta suggella la tregua e sembra voler ricomporre nella perfezione del cerchio cangiante di colori le sparse membra del mondo. Nella cornice stupefacente dell'arcobaleno che si staglia in un cielo terso riappaiono le cose nei loro chiaroscuri, nella loro prospettiva, nella meraviglia dei loro colori. In altre parole: riappare il cosmo, il mondo ordinato nella sintassi fisica, nella verità logica e nell'armonia etica. Nel processo diacronico della differenziazione dall'omogeneo, o per meglio dire nello stagliarsi degli oggetti mobili e differenti su uno sfondo omogeneo ed immobile, la meraviglia funge da primo elemento generatore della conoscenza.
Il secondo è il dubbio. Dice, infatti, Aristotele: "In virtù della meraviglia gli uomini iniziarono a filosofare: da principio si meravigliano di quelle cose di cui il dubbio era più facile e quindi procedettero a dubitare delle cose maggiori⦠Colui che si meraviglia e dubita sa di essere ignorante; per cui il filosofo è anche amante del mito: il mito consiste di cose meravigliose...".[8]
Se la meraviglia genera il mito (la parola che racconta la meraviglia), il risolvimento del dubbio genera la scienza.
Ma fra queste esiste un altro momento intermedio (che è diverso dal primo, pur senza toglierlo e prepara il secondo), ossia la storia, la descrizione dell'accadere. Ricordiamoci che il termine istor (la radice è id, idein, video) in Omero significa testimone visivo.
Le forme linguistiche entro cui si presentano queste tre attività sono profondamente diverse se commisurate con il concetto di verità inteso come rapporto di adeguazione al reale. La forma del mito e della storia è il racconto (il primo racconta il meravigliarsi dell'uomo e la seconda la sua testimonianza empirica), mentre la forma della scienza è il logos, la spiegazione secondo âverità â. Nel primo caso, il linguaggio esprime la constatazione del "che è", descrive il fenomeno nel processo metamorfico del suo apparire, riproponendo nella parola del mito lo stupore, la meraviglia e in quella della storia il referto dei sensi; nel secondo caso, la meraviglia lascia il posto al dubbio ed al linguaggio che lo esprime.
Il primo resoconto âstoricoâ sul mondo è un resoconto mitico, ossia fatto attraverso la paÂrola che racconta la meraviglia. Questo non è altro che la potenza del favoleggiare, lâuso maÂgico della parola, il che è un bisogno dellâuomo ancor più imperioso di quanto lo è quello del ragionare o, per meglio dire, come ci ha spiegato Piaget, il mondo del bamÂbino è innanzitutto magico-mitico e solo più tardi, come lo è nelle civiltà più adulte, diÂverrà loÂgico e nomologico-inferenziale.
Lâattestazione del âche le cose stanno cosìâ comporta, in questa prospettiva, anche la risposta alla domanda del âcome stanno le coseâ. La descrizione dellâosservazione traÂdotta nella parola mito-poieÂtica (lo stupito silenzio della meraviglia che si trasforma in paÂrola creatrice) risponde ad ambedue le esigenze. Lâintero ciclo omerico è testimone del fatto che nel momento in cui si descrive la struttura mitopoietica del mondo si dà anche ragione di come funzionano le cose. La ânaturaâ risponde sempre nello stesso linguaggio con il quale la si è interrogata: essa è prima di tutto il dominio del poeta e dellâartista, quindi del teologo e del moralista e solo molto più tardi del filosofo e dello scienziato e, nel suo insieme, non è mai separata dal destino dellâuomo in quanto essa rappresenta per lâuomo che la osserva un immenso siÂstema di segni che di tale destino si fa portatore.
Il concetto di âscienzaâ
E' necessaÂrio chiarire cosa abbia inteso il pensiero classico con il concetto di âscienzaâ. Solo così è possibile incominciare a capire quale sia efÂfettivamente il portato di ânovità â della rivoluzione scientifica del XVII secolo e nellâEtà dellâIlluminismo e anche che cosa sia la âscientificità â oggi.
Con Platone si assiste alla fondazione del conÂcetto di scienza come sapere in grado di garantire la propria valiÂdità e quindi di permettere a chiunque di controllare l'affidabilità delle proprie affermazioni, a differenza del concetto di opiÂnione (sia pure opinione corretta) che non presenta tale requisito. Platone paragona l'insicurezza dell'opinione e l'instabilità del suo "sapere" alle statue di Dedalo, le quali davano all'osservatore una tale impressione di moÂvimento che questi se le vedeva sfuggire dinnanzi, incapace di fermarle e di gustare più a lungo della loro indubbia bellezza. Tali statue, infatti, pur essendo assai belle a veÂdersi, non hanno più valore di uno schiavo che se la sia svignata, sicché diventa necesÂsario legarle; "allo stesso modo - continua Platone nel Menone, 87c, - le opinioni veraci finché rimanÂgono sono belle e buone, ma non restano a lungo e purtroppo lasciano gli uominiâ. Di conseguenza non è che abbiano molto valore fintantoché non si riesce a legarle attraÂverso un ragionamento causale. Dopo che siano state legate esse diventano conoÂscenze e quindi stabili. PerÂciò la conoscenza è molto più pregevole della retta opinione proprio in virtù di quel leÂgame[9].
Nella fisica milesia l'antica determinazione di causa-colpa gioca un ruolo fonÂdaÂmentale: âdonde viene la nascita per le cose, in ciò si compie anche il loro dissolviÂmento secondo necessità ; pagano il fio reciprocamente e la pena dell'ingiustizia nell'ordine del tempoâ (Anassimandro - Diels - DK 12 A9). Più tardi con Platone il conÂcetto di causa prende una caratura molto precisa, identificandosi con l'esigenza sinÂtetica del Logos. La ricerca di tale legame (si noti che âcausaâ è un termine semanticamente molto ampio ed articolato e, in sostanza, viene identificato con l'esigenza del logos, il âdar ragione diâ) è il momento inesitabile e l'aspetto più caratteristico del problema gnoÂseologico. Sia la scienza (le âfilosofie secondeâ) che la filosofia, infatti, assumono in partenza che l'immediato non sia l'originario o, in altre parole, che l'esperienza, non avendo in sé la propria raÂgione, esige di essere ulÂteriormente giustificata. Il problema fondamentale, da cui nasce quel momento eccezioÂnale che è la filosofia greca o, per meglio dire, il modello della raÂzionalità filosofica, è quindi quello del reperimento di un legame in virtù del quale sia possibile spiegare ciò che è accertato dall'esperienza. Quest'ultima, infatti, da sola può al più produrre una casiÂstica, ma non è in grado di operare sinteticamente, ossia di far emergere dal fenomenoloÂgico ciò che questo non può dare e cioè la risposta al perché. A tale compito, quindi, dare ragione di ciò che l'esperienza attesta, ma ancora non spiega, è chiamato il logos. E' in questa speciÂfica accezione che la cultura occidentale riÂconosce la nozione fondamentale di episteme (scienza): conoscenza realizzata attraverso l'atto di sintesi che il logos opera sull'empiria, ossia attraverso il reperimento di una raÂgione che sia in grado di giustificare l'esperienza. L'intervento del logos non è chiamato a rendeer certo ciò che già lo è (i sensi accertano che è), ma a fornirne la ragione (la raÂgione è chiamata in gioco per fornire il perché dell'esperienza).
In altre parole: lo sforzo di giustificare il noto è diverso dallo scoprire l'ignoto. La domanda filosofica che assume le forme del che cosa? e del perché? introduce semÂpre la mediazione dell'esperienza attraverso tre momenti: l) la determinazione della struttura dell'immediato (il cosa è ciò che è); 2) la modalità di questi (il come è ciò che è); 4) la ragione di questi (la domanda sul perché, ossia l'indagine sulla causa e sul princiÂpio). Tali ragioni si riconducono ad alcuni tipi fondamentali: il che cosa (l'essenza), le cause dei fenomeni, i principi in base ai quali se ne dà ragione.
Il trascendimento dell'immediato porta ad un originario che è l'essenza, la quale si dà come originario in quanto risponde all'esigenza di comprendere il molteplice immediato (il diverso) attraverso l'identico (l'unità da cui si genera il molteplice). In seguito, quÂando ci si chiede il perché l'immediato non è l'originario o perché l'identico si presenta come diverso, allora affiorano i due sensi del concetto di causa: quello per cui è origine e principio del molÂteplice e quello per cui è la necessità , la forza che trae dall'uno il molteplice. In questa prospettiva arché e dunamis hanno il duplice valore logico e ontologico di essere relaÂzioni fondanti tanto in senso ontologico che logico.
Il nesso causale è originariamente una specie di traduzione globale dellâistanza del logos nei confronti dell'immediato ed è per questo motivo che alle successive codificaÂzioni di questo concetto si verifica una riconosciuta polisemia: la dottrina delle quattro cause ariÂstoteliche risponde al fatto che possono essere riconosciute come causa (ragione) di un essere anche la forma e il fine, accanto alla ragione logica e alla causa produttiva. La causa, nella speculazione aristotelica, è in definitiva la relazione con un fondamento: una relazione fondante, ossia ciò che dà ragione in più sensi non unificabili. La polisemia del concetto di causa deriva dall'alterità che è propria di ogni rapporto (riferimento di qualÂcosa a qualcos'altro, distinzione fra fondamento e ciò che è fondato). In questa prospetÂtiva se penso la causa come ragione istituisco un rapporto di fondazione logica, se la penso come causa efficiente ho un rapporto ontologico di produzione, se la penso come causa finale ho un rapporto fra un disegno interno all'essere in relazione al divenire ... e così via. La nozione di causa si polisemantizza e acquista, così, la stessa estenÂsione delle sue sfere di applicazione.
La ricerca di tale legame (si noti che per i Greci âcausaâ è un concetto polisemico che si identifica con il logos) è il momento inevitabile e l'aspetto più caratteristico del problema gnoseoloÂgico: sia la scienza che la filosofia, infatti, assumono in parÂtenza che l'immediato non è l'originario o, in altre parole, che l'esperienza, non avendo in sé la propria ragione, esige di essere ulteriormente giustificata.
Il distacco della âscienza modernaâ dalla filosofia
In un celebre passo del De Homine, T. Hobbes, dopo aver posto la distinzione fra scienza (âla conoscenza a partire dalle cause, vale a dire dalla generazione dellâoggettoâ) e cognizione (la quale si occupa delle verità di fatto), dichiara che: âagli uomini è stata concessa la scienza solo di quelle cose la cui generazione dipende dal loro stesso arbitrioâ[10]. Quali siano poi, in particolare, queste cose di cui è data scienza Hobbes lo precisa subito dopo: âSono pertanto dimostrabili i teoremi sulla quantità , la scienza della quale si chiama geometria. Dato che le cause delle proprietà delle singole figure stanno nelle linee da noi medesimi tracciate, e la generazione della figura dipende dal nostro arbitrio, per conoscere la proprietà di una figura basta considerare tutti gli elementi impliciti nella costruzione fatta da noi medesimi quando abbiamo disegnato la figura. Di conseguenza esiste una geometria ed è dimostrabile proprio perché siamo noi stessi a creare le figure ⦠Anche lâetica e la politica, ossia le scienze del giusto e dellâingiusto, dellâequo e dellâiniquo, si possono dimostrare a priori, dato che i principi grazie ai quali si conosce il giusto e l'equo ed i loro contrari ... li abbiamo costruiti noi stessiâ.[11] Nel caso della fisica, invece, Hobbes scrive: â... poiché le cause delle cose naturali non sono in nostro potere, ma nella divina volontà ... non è possibile dedurre le loro proprietà dalle loro cause. Ci è concesso, invece, di procedere deducendo le conseguenze da quelle proprietà che cadono sotto la nostra percezione, fino ad ottenere la dimostrazione che la loro causa potrebbe essere questa o quella ... Ma, dato che negli eventi naturali che dipendono dal moto non è possibile procedere a posteriori senza cognizione di ciò che consegue ad ogni tipo di moto ed a tale cognizione non si perviene senza conoscere la geometria, ne consegue che anche il fisico procede a prioriâ[12]. Nel corso di questa pagina hobbesiana, scritta nei primi anni della seconda metà del XVII secolo, ossia quando la scienza moderna da poco costituitasi aveva già iniziato a riflettere sui propri fondamenti epistemologici, troviamo per intero la banda delle frequenze filosofiche sulla quale si era venuto a sintonizzare, durante il processo di gestazione della ârivoluzione scientificaâ, il pensiero degli ultimi cento anni.
In primo luogo: la drastica restrizione di significato del concetto di causa. Il passaggio, cioè, dalla polisemia classica, implicita nella concezione aristotelica della âcausaâ come ârelazione fondanteâ, allâunico significato ammesso dalla scienza moderna, ossia quello in cui il nesso causale coincide senza resti con il nesso di produzione dell'oggetto.
In secondo luogo: il presupposto della necessaria congruenza e reciprocità fra il conoscere ed il fare, esplicitata nellâaffermazione di principio che sono conoscibili solo quelle cose che, come dice P. Mersenne (che di tale idea è il primo lucido assertore): ânoi possiamo costruire con le mani o con l'intellettoâ[13].
In terzo luogo: la demetafisicizzazione delle scienze naturali. La esplicitazione, cioè, del fatto che il compito fondamentale della fisica non è la ricerca delle essenze, ma (secondo la celebre dizione di Galileo) la determinazione di âalcune affezioniâ degli enti o eventi naturali. Da questa, poi, è possibile risalire alla loro causa fiendi, che è in definitiva lo scopo primario a cui la scienza tende dato che, entro la prospettiva dellâabbandono dellâimpegno metafisico, la causa essendi risulta ininteressante, anche qualora non venisse dichiarata in via di principio irraggiungibile.
In quarto luogo: la necessità di matematizzare natura e scienza. Ciò per due ordini di ragioni: innanzitutto perché lâunica possibile traduzione letterale, non metaforica, dal linguaggio in cui è scritta la natura a quello per cui lâuomo non solo ne parla, ma anche la conosce, è la formalizzazione matematica. Secondariamente perché si pensa che tale procedimento sia lâunico che può garantire quella forma di sintesi fra il razionale e lâempirico che rappresenta lâideale della gnoseologia moderna.
Questo ventaglio tematico si instaura attorno al nucleo originario della scienza moderna; lâabbandono della pretesa metafisica di trovare sempre e comunque le condizioni necessarie e sufficienti in grado di giustificare lâesperienza; proposta, questa, alternativa al paradigma classico della razionalità filosofica.
Il paradigma del sapere filosofico, infatti, scandito sullâistanza di assolutezza e totalità ed inteso, quindi, a legare lâimmediato allâoriginario secondo nessi di conseguenza logica, comporta che si renda conto della mediazione sia sotto la luce dell'essenza che delle cause necessarie. A questa pretesa la scienza moderna rinuncia, disimpegnandosi intenzionalmente dal compito tipico della metafisica, ma reimpegnandosi progressivamente sul piano dellâepistemologia e della teoria della conoscenza al fine di costruire un modello di razionalità non-filosofica. Desideriamo, invece, evidenziare che la problematizzazione dello gnoseologico come primo, ma non certamente unico, rango del filosofico si impone allo storico come momento altamente rilevante nella cultura occidentale dal XVII secolo in poi. Non è infrequente, comunque, sentirsi obiettare che entro il pensiero scientifico moderno tale problematizzazione del gnoseologico si accompagna alla dissoluzione del medesimo, in quanto la rivoluzione scientifica si caratterizza proprio come lâabbandono del punto di vista noetico della scienza in favore di quello pratico. Da questo punto di vista, la scienza non solo viene considerata la figlia primogenita della tecnica, ma addirittura coincidente con questa, tanto che al suo tradizionale valore conoscitivo vengono sostituiti quegli aspetti pragmatici in ragione dei quali scienza e tecnica possono essere pensate come strumenti per manipolare le cose. Per quanto ci riguarda, siamo in profondo disaccordo con tale posizione, sia perché pretende di spiegare un periodo di profonde trasformazioni della coscienza collettiva con uno schema che lascia fuori troppo e dà ragione di troppo poco, sia perché reputiamo che lâaffermazione che la tecnica abbia generato la scienza sia un clamoroso falso storico costruito su mezze verità . Dâaltra parte, speriamo di evidenziare che, almeno per quel che concerne il XVII secolo, il prezzo che bisogna pagare per sostenere lâindiscernibilità di scienza e tecnica comporta unâevidente scorrettezza logica e cioè che lâesperienza abbia prodotto da sola lo strumento in grado di riformare quelle stesse idee che tale esperienza avevano reso possibile.
Questa consapevolezza ci sarà indispensabile per controbattere la tesi che vuole motivare la caduta del tabù del naturale come una conseguenza dellâimporsi del progresso tecnologico. Sta di fatto, poi, che se non si vuol correre il rischio di farsi smentire dagli stessi Autori della rivoluzione scientifica bisognerebbe, ad esempio, non prendere in considerazione la maggior parte delle opere di Cartesio, Keplero e Galileo, tradurre frasi come la celeberrima baconiana âipsissimae res sunt veritas et utilitasâ[14] lasciando credere che in latino ipse è un doppione di idem, assumere le invettive di Palissy[15] contro i teorici o il radicale e spregiudicato strumentalismo di Roberval, come se questi fossero i precetti architettonici sui quali si è costruita la scienza moderna, o fingere che Stevino e Tartaglia fossero essi stessi artigiani, o che lâuso della lente sia stata condizione necessaria e sufficiente per la nascita della meccanica celeste e della fisiologia meccanicistaâ¦
Da parte nostra, siamo convinti che la funzione della tecnica sia stata più sociologica che teoretica e proprio per questo pensiamo che la funzione dellâartigiano, nella cultura del XVII secolo, non possa essere assolutamente tralasciata dalla storia del pensiero scientifico. Dâaltra parte, non possono neppure essere tralasciati altri momenti rilevanti, quali lo spostamento di interesse dalla teologia alla filosofia naturale, la sistematica applicazione del metodo induttivo e di procedimenti matematici allo studio del mondo fisico, le sempre più pressanti critiche contro lâaristotelismo e la scolastica, lâabbandono del già costituzionalmente debole principio di autorità ed evidentemente anche il cambio di prospettiva dellâuomo verso la natura, ossia il passaggio dalla teoria della vita contemplativa a quella della vita attiva, il risveglio tecnologico e lâestensione dellâuniverso dei sensi provocata dal progressivo ampliamento dell'aldilà empirico della percezione, la rivalutazione del mito di Prometeo ed Icaro e lâimporsi della mentalità del Doctor Faust. In realtà , però, lâinsieme di tutti questi fattori, sintomatici della nascita di una nuova âspecieâ culturale, appartengono, a nostro avviso, allâanamnesi di questa e, qualora non fossero accompagnati dalla specificazione e caratterizzazione diagnostica della nuova mentalità , rappresenterebbero al più una sia pur completa fenomenologia dell'iter preparatorio di quellâevento storicamente eccezionale che è il distacco della scienza dalla filosofia.
Non a caso abbiamo iniziato questo paragrafo lasciando che fosse uno dei padri fondatori del meccanicismo a comporre il mosaico delle tematiche sulle quali era venuto via via a precisarsi il concetto di scienza. Sia detto, comunque, per inciso che tale scelta non è ad hoc, dato che avremmo potuto benissimo trovare gli stessi concetti esplicitati nelle opere di tutti i maggiori scienziati dellâepoca, sia pur con diversi accenti di evidenziazione.
Va da sé, però, che ognuno di questi temi (o tessere del mosaico), preso separatamente, non permette che ne risulti lâintera figura culturale della rivoluzione scientifica. Ad esempio, Cartesio, fin dal âcoepi intelligere fundamentum inventi mirabilisâ[16] del 1619, pensa alla matematizzazione della natura e della scienza, ma non per questo intende rinunziare a trattare con le essenze, ossia ammettere una demetafisicizzazione del mondo naturale. Al contrario Bacone che, almeno a parole, traccia il percorso della demetafisicizzazione, non mostra alcuna propensione (anzi, oppone un netto rifiuto) alla matematizzazione dell'oggetto e della teoria. La riduzione del nesso causale, poi, a nesso di produzione non può fungere da sola caratteristica specifica della scienza moderna perché, diversamente, dovremmo non prendere in considerazione né il concetto di forza né quello di fine sul quale, specie in fisiologia ed embriologia, ruotano le basi della medicina positiva. Così pure per quanto riguarda il presupposto della congruenza fra il fare ed il conoscere, il quale, essendo accettato dalla cultura del XVII secolo nell'accezione che si dà di scienza di quelle cose di cui si è o si sa la causa efficiente o delle quali è costruibile un modello teorico, preso separatamente dalla matematizzazione di scienza e natura e dalla demetafisicizzazione del conoscere risulta assolutamente inconcepibile.
La nascita del modello della razionalità scientifica, avvenuta per distacco dalle comuni radici che per secoli condivisero scienza e filosofia, è un evento che per intensità culturale non può essere paragonato che a pochi altri momenti della storia della cultura occidentale, quali ad esempio il sorgere in terra greca della razionalità filosofica o la nascita di un modello conoscitivo non più fondato sullâassoluta determinatezza e prevedibilità dei fenomeni, quale è quello che sta informando la nostra epoca. Più le grandi modificazioni degli statuti culturali sono profonde e meno esse si lasciano ricondurre a schemi; esse esigono di essere comprese nella pluralità delle loro dimensioni e, pur permettendo (come è necessario) che lo storico segua un disegno, un tratteggio o un abbozzo, a tale schema sfuggono quando esso si presenta con un alto tenore di definizione. La rivoluzione scientifica del XVII secolo ha comportato in particolare una profonda crisi di estroversione della coscienza collettiva: la natura, sottoposta ad una interrogazione dal cui linguaggio erano state bandite quelle categorie antropomorfiche che di lei avevano fatto lo specchio delle paure e dei bisogni dell'uomo, delle sue miserie e grandezze, incomincia ad offrirsi come un meccanismo autonomo, dotato di leggi sue proprie e fondato su suoi specifici principi.
Allâidea greca di Cosmo, in cui tutto è scandito nella sintassi fisica, nella verità logica e nell'ordine etico, si sostituisce la moderna idea di Natura in cui Dio, uomo e mondo non solo appartengono ad ordini diversi, ma hanno anche da essere compresi in maniera diversa. âLa natura ha perfezioni per mostrare lâimmagine di Dio - scrive Pascal - e difetti per mostrare che essa ne è soltanto lâimmagineâ[17]; e ancora: âNon dallo spazio devo cercare la mia dignità , ma dal regolarsi del mio pensiero ... con lo spazio lâuniverso mi inghiotte e mi contiene come un punto; con il mio pensiero sono io che lo contengoâ[18]. Fisica e teologia divergono quanto possono divergere la religione dalla tecnica, la carità dallâutilità ; esse si staccano perché poco hanno in comune la conoscenza di Dio con quella della natura. Eâ sempre Pascal ad affermare che lâintero sapere sul mondo naturale non vale il più piccolo moto di carità [19] e che per conoscere Dio è necessaria la mediazione di Gesù Cristo, mentre per conoscere il mondo naturale può bastare il ricorso allo schema cartesiano per il quale tutto avviene per moto e figura[20].
Il pensiero di Pascal, si badi, è più emblematico che eccezionale per il suo tempo, un tempo in cui gli scienziati accanto al loro laboratorio hanno il loro oratorio e sanno distinguere lâuno dallâaltro. Gassendi, ad esempio, che è temperamentalmente differente da Pascal o, perlomeno, è tutt'altro che un mistico, pur ponendosi costantemente il problema di Dio, afferma con certezza che a tale scopo la scienza non serve[21]. Mersenne, invece, la pensa diversamente e, pur essendo convinto che quando la Verità ci sarà svelata potremo anche trovarci nelle condizioni di dover ammettere che essa contraddice le nostre convinzioni terrene ricavate con lâaiuto della scienza, annette unâenorme importanza allo studio della fisica, facendone uno dei modi per guadagnarsi la vita eterna[22]. Il che evidentemente non è come dire che con l'aiuto della scienza si dimostra lâesistenza di Dio, ma che la pratica della fisica ci avvicina al Creatore. Anche Bacone e Cartesio sono convinti, come è noto, che la scienza, intesa come conversione dellâuomo verso le creature, sia uno degli strumenti della salvezza in quanto significa elevazione e liberazione dellâuomo dai suoi bisogni materiali in modo che gli sia permessa la cura della sua anima.
L'uomo del XVII secolo, che pure sente il bisogno di dare un senso, di giustificare la sua scienza sul piano morale, non pensa che l'aver rinunciato alle essenze comporti una devitalizzazione della sua attività conoscitiva, la quale non essendo più intesa a ricercare gli Eterni Modelli, ma a rapportare fra loro i fenomeni e a generalizzare tali rapporti, avrebbe potuto dare lâimpressione di essere o gioco o pura manipolazione delle cose. In altre parole: egli non reputa che lâabbandono delle essenze comporti una sconfitta della dimensione noetica, né tanto meno che il fatto di non voler più riportare le cose ai primi principi significhi rinunciare alla conoscenza di Dio e del mondo.
Se esista o meno una realtà al di sotto delle apparenze è un problema che allo Scienziato non interessa: quel che a lui interessa e basta, dice Mersenne, è âconoscere le cose per quel tanto che ci sono proporzionateâ[23]; al resto, aggiungerà Roberval, ci pensino pure i metafisici.
I sensi, dirà Mersenne, non si limitano alla pura registrazione, ma compiono delle integrazioni e così facendo, col proporzionarsi alle cose, in realtà le sproporzionano. La ragione in seguito restaura unâautentica proporzionalità fra conoscenza e realtà . Essa, essendo la facoltà che istituisce i rapporti fra i dati dei sensi e corregge la loro soggettività trattandoli quantitativamente, può raggiungere una vera e propria adeguazione del conoscere al reale. Tale adeguazione, che in definitiva si riduce allâinterpretazione dei fenomeni in chiave di moto e figura, si basa sul presupposto che la natura è matematica e sul dato di fatto che con lâuso della matematica i conti tornano, ossia si riesce ad annullare quel qualcosa in più che i sensi hanno aggiunto allâoggetto.
Ciò comportava che si approfondisse lo studio dellâattività conoscitiva sia dal punto di vista fisiologico che dal punto di vista fenomenologico, in quanto la classica teoria della conoscenza andava rivista a partire da una rifondazione della fisiologia e psicologia della percezione e dalla ricalibrazione della fenomenologia della conoscenza. Sotto questa prospettiva, testimoniata d'altronde dal fervore di studi in fisiologia della sensazione, dal lavoro di meccanizzazione delle qualità sensibili operato dalla psicologia meccanicista e dalle analisi fenomenologiche della conoscenza, la scienza cerca di giustificare teoreticamente il proprio diritto di cittadinanza nella sfera noetica e non solo in quella pragmatica, che nessuno si sarebbe sognato di negarle.
Entro questo tipo di lavoro era evidente che lâoggetto primario di studio diventava lâuomo e ciò per due ordini di motivi: primo, perché esso è il soggetto della conoscenza e, secondariamente, perché esso presenta un incontestabile valore di trascendenza rispetto alla natura, pur essendo cosa fra le cose.
Lâuomo, che fino ad allora si era trovato sospeso fra la terra e il cielo, indeciso a quale delle due sfere appartenere, trova la sua collocazione. Non angelo né bestia, dirà Pascal, ma macchina e mente nello stesso tempo âse non vogliamo ingannarci nel conoscere noi stessiâ[24]. Il corpo, liberato dal privilegio della âextraterritorialità â, diviene corpo fra i corpi, sottoposto alle stesse leggi che governano lâuniverso materiale, mentre la mente, lâanima, lâinsieme di sentimenti e ragioni permettono allâuomo un posto a parte nella Creazione.
La filosofia, che sembrava relegata dalla scienza alla sterile quanto inutile ricerca degli Eterni Modelli, trova il suo spazio teoretico nell'opera di dimostrazione dell'esistenza dell'uomo.
La scienza, che pure si era impadronita del corpo umano facendone uno degli oggetti primari della sua ricerca, è convinta, almeno per quanto riguarda il XVII secolo, che lâuomo non è soltanto il suo corpo e si incarica di collaborare su questo punto con la filosofia, fornendole il materiale di costruzione di unâantropologia filosofica che tenga conto di ambedue gli aspetti. Abituati come siamo ad assumere il pensiero cartesiano come il verbo antropologico del secolo, solitamente ci sfugge il fatto che il dualismo antropologico è molto meno generalizzato culturalmente di quanto si creda, tanto più che a questo non si è opposto soltanto il materialismo hobbesiano.
Mersenne nelle Quaestiones in Genesim[25] sostiene che 1âuomo è unione di anima e corpo e che esso può venire definito solo con il ricorso ad ambedue i concetti. Nellâambito della conoscenza, egli afferma, e cioè in quellâambito entro il quale si cerca la certezza razionale dellâesperienza di sé, nessuna delle due può operare senza lâaltra. Pascal, che vede la dignità dellâuomo nel suo pensiero, non trova così evidente come Cartesio il fatto che lâuomo sia soltanto la sua anima, anzi lo definisce unione di spirito e macchina, tanto più, egli dice, che quando la macchina funziona male anche la mente ne risente. A lui, infatti, non piacciono gli eccessi e quel che sta mascherato sotto la querelle del cogito sono coppie di opposti (quali razionalismo-empirismo e materialismo-spiritualismo), che sono in effetti, come dice nel Frammento 254, veri e propri eccessi.
Marin Mersenne
Da parte medica, poi, lâirriducibile dualismo non viene neppure preso in considerazione. Da Vesalio ad Harvey, Baglivi e Malpighi si generalizza lâopinione che l'uomo può essere definito soltanto se si tengono presenti ambedue le dimensioni e che se il medico deve accontentarsi sul piano terapeutico di "levare gli impedimenti dell'anima operante" [26], sul piano della costruzione della sua teoria deve tener conto dellâuomo nella sua totalità .
In definitiva: non è che Cartesio, come di solito si è portati a credere, distinguendo i due ordini irriducibili di anima e corpo abbia permesso il sorgere della medicina positiva; anzi, è proprio vero il contrario e cioè che lâidea del corpo umano come uno dei corpi naturali, sottoponibile quindi allo schema di moto e figura, pone a Cartesio il problema della salvazione della trascendenza dellâuomo rispetto alla natura. Tale trascendenza non può essere, evidentemente, garantita dal corpo allo stesso modo che, in gnoseologia, non è possibile garantire la realtà soltanto con la rappresentazione.
Un fenomeno, quindi, come la nascita della scienza moderna, il quale ha prodotto mutazioni genetiche nellâambito della cultura occidentale e non ha soltanto modificato il modo di praticare le scienze cosiddette empiriche, non può esser compreso che dai segni distintivi che quella stessa cultura dà di sé. La nascita di una nuova specie culturale, così come accade per la nascita di una nuova specie biologica, contiene segnatamente in sé i modelli precedenti, a partire dai quali ha sintetizzato la sua nuova forma e questi non possono essere completamente cancellati. Le nuove caratteristiche non sono, infatti, lâesatta negazione delle precedenti. La cultura dellâepoca moderna, caratterizzata dal distacco della scienza dalla filosofia, non è composta come un mosaico a cui sono state sostituite le vecchie tessere con altre completamente diverse, ma come un disegno in cui la nuova disposizione delle figure ha modificato la forma globale.
Vi è però un tema emblematico nella cultura del XVII secolo, il quale, pur essendo ricavabile (e in realtà è stato ricavato storicamente proprio in tali termini) come corollario della matematizzazione di natura e scienza, acquista una tale rilevanza da assurgere ad idea guida della cultura dellâepoca. Ci riferiamo alla caduta del tabù del naturale, concretizzato nella dimostrazione che tutto ciò che è naturale è di per ciò stesso artificiale.
Lâidea che tutto avviene âper moto e fıguraâ deriva dalla matematizzazione della fisica; allo stesso modo, anche la predicazione della naturalità allâartificiale, derivata dalla nuova definizione del termine ânaturaleâ come ciò che risponde alle leggi della geometria e della meccanica, è un corollario della matematizzazione della fisica. Su questi due aspetti della stessa idea si incentra, secondo noi, la cultura del XVII secolo: sul primo si costruirà la fisica e si determinerà il sorgere dellâimmagine meccanicistica della natura; sul secondo si costruiranno la fisiologia e la medicina e si determinerà il sorgere dellâantropologia meccanicista.
Scienza e filosofia si presentano storicamente legate, in modo inscindibile, ad una comune radice teoretica, sì che fino alle soglie dell'Età Moderna esse sono state considerate pressoché identiche. La loro separazione avviene nel momento in cui sorge la neÂcessità di precisare, in conformità ai fini conoscitivi, la natura del legame che permette di connettere l'esperienza al logos: la filosoÂfia, mirando ad unâistanza conoscitiva di totalità ed assolutezza, richiede che la spiegazione avvenga attraverso il nesso di conseÂguenza logica, mentre la scienza, mirando ad istanze conoscitive più circoscritte, s'accontenta del nesso di ragion sufficiente. In altre parole: la filosofia considera soddisfatte le proprie intenÂzioni conoscitive solo quando le ragioni poste a giustificazione dell'esperienza siano condizioni necessarie e sufficienti per dare ragione di questa, mentre la scienza s'accontenta semplicemente del fatto che queste ragioni siano perlomeno condizioni sufficienti.
Nel momento in cui la scienza moderna nasce per distacco dalla filosofia e per comune condivisione delle stesse radici, si assiste alla drastica restrizione del signifiÂcato del conÂcetto di causa, il che comporta il passaggio dalla polisemia classica, implicita nella concezione aristotelica della causa come relazione fondante, all'unico significato ammesso dalla scienza moderna, ossia quello in cui il nesso causale coincide senza resti con il nesso di produzione (la causa efficiente). Di nuovo monosemico il concetto di causa percorrerà la strada inversa e opposta a quella lungo la quale il pensiero arcaico aveva camminato all'inizio: non sarà più il mondo umano a proporsi come modello per la spiegazione del mondo naturale, ma il contrario. Questo porta ad una frattura che è ben più profonda di quanto potrebbe sembrare a prima vista: la filosofia si trasforma sempre più in un apparato formale dove le sue proposizioni trovano giuÂstificazione nella sua stessa struttura logica, la sua verità è "verificata" all'interno del sistema; la scienza cerca verifiche all'esterno e, inconsapevolmente, tende ad abbandonare la sfera noetica (della conoscenza) per quella pratica (dell'utilità tecnoloÂgica). Detto in altre parole: la filosofia cerca giustificazioni all'interno del proprio discorso, mentre la scienza sfuma la verità entro la condizione dell'utilità (la prima fonda la verità sulla coerenza logica e la seconda sull'utilità dei risultati pratici). Ma così facendo la scienza perde di vista, almeno in parte, la spinta "sapienziale" che induce l'uomo non solo a sapere come avvengono le cose e a cosa servono, ma fondamentalmente a porsi le cosiddette domande ultime sul significato dell'essere. D'altra parte, questo è lo specifico della scienza, ossia l'accontenÂtarsi di dare ragione del mondo dei fenomeni. Da questo momento in poi (che coincide, appunto, con la naÂscita della scienza moderna agli inizi del XVII secolo) assistiamo ad un proporsi sempre più massiccio della filiazione scienza-tecÂnica e ad una deprivazione degli aspetti autenticamente noetici della scienza.
  Ma lâaver riconosciuto che il divenire del mondo rappresenta lâestrema minaccia in quanto in esso abitano le metamorfosi, le nascite e le morti, lâuscire dal Nulla e il rientrare nel Nulla, ha portato di necessità lâOccidente a percorrere la strada dellâepiÂsteme, il percorso della scienza, il cammino che tende a costruire una conoscenza incontrovertibile, ossia un sapere che âsta fermoâ (episteme) nella âverità â.
  Ma via via abbiamo perso il significato del termine aletheia, sostituendole il concetto di verità -utilità , dando credito a quelli che traducevano âla stessa medesima cosa sono la verità e lâutilità â di Bacone, facendone così non solo un pessimo filosofo (sbagliandosi, perché era soltanto un inesistente scienziato, ma un originale e genuino filosofo), bensì anche un inaccettabile latinista (e questo è falso).
Dallâestetico allâestatico
Lâesperienza[27], il saldo legame che tiene lâuomo entro i limiti della percezione sensoriale, accerta lâaccadere istituendo il primo e fondamentale contatto fra lâindividuo e la realtà ma, non avendo in sé la propria giustificazione, esige di essere trascesa chiamando in gioco la ragione.
   Fin dai primordi della speculazione ellenica, questa consapevolezza fondamentale (ossia che il referto dei sensi non è lâoriginario), dalla quale nasce la stessa razionalità filosofica, è generalmente da tutti condivisa. I sensi costituiscono il luogo del contatto immediato, mentre la ragione è il momento elettivo della mediazione, vale a dire la spiegazione intesa come sintesi fra il logico e lâempirico. Il fermarsi, infatti, al semplice referto sensoriale non porta da nessuna parte, è una strada senza via dâuscita. Riconoscere, dunque, che l'immediato non è l'originario, non comporta mai come soluzione l'arresto all'immediato, quanto piuttosto l'identificazione dell'originario.
   Il trascendimento dell'immediato porta ad un originario che è l'essenza, la quale si dà come originario in quanto risponde all'esigenza di comprendere il molteplice immediato (il diverso) attraverso l'identico (l'unità da cui si genera il molteplice). In seguito, quando ci si chiede perché l'immediato non è l'originario o perché l'identico si presenta come diverso, allora affiorano i due sensi del concetto di "causa" [ragione]: quello per cui è origine e principio del molteplice e quello per cui è la necessità la forza che trae l'uno dal molteplice.
Questa strada non è stata percorsa soltanto dalla razionalità filosofica (che ha teorizzato, quale immediato, il dato dâesperienza), ma prima ancora di questa e, quindi, parallelamente a questa, dalla âmisticaâ: il cammino (costruito, al contrario, sullâintuizione estatica) che tende alla comunicazione diretta (senza mediazioni) con il divino come alternativa escludente la via della ricerca razionale .
L'epifania del divino è una tipica informazione di presenza, è un rivelarsi di una realtà altra la quale si manifesta sostanzialmente nel superamento dellâesperienza sensoriale. Il termine estasi indica lâazione del dislocare o meglio indica lâuscir fuori da ciò che sta saldo: lâepisteme (la conoscenza costituita sul fondamento). La percezione sensoriale (lâaistesis)[28] sta costituzionalmente alla base del processo conoscitivo tipico dell'episteme, il percorso della scienza, il cammino che tende a costruire una conoscenza capace di garantire la propria validità , ossia un sapere in grado di "star fermo" (epistemi) nella verità .
Il viaggio che conduce dallâestetico allâestatico trova, naturalmente, il proprio veicolo elettivo nellâarmonia intesa come rivelazione-manifestazione della realtà suprema o, per meglio dire, di una sua caratteristica fondamentale: la divina concordanza che pervade lâuniverso, un sapere privilegiato che ha come oggetto quella particolare trama (lâarmonia appunto) di cui è ricoperta la Verità [29], quel velo metafisico che le rende possibile, ad opportune condizioni, di manifestarsi agli uomini.
La concezione che tutto è numero ed armonia (ton ojvlon oujranon aJrmonivan ei'jnai kai ajriqmovn), ossia che lâordine divino del cosmo è, in certa misura, accessibile alla mente umana, porta direttamente allâidea che la musica[30], avendo caratteristiche analoghe a quelle dellâarmonia cosmica, sia il mezzo privilegiato per elevarsi alla conoscenza di quella divina armonia che si diffonde e compenetra lâintero universo. Questa dottrina, genericamente catalogata come orfico-pitagorica, ancora prima dâessere interpretata come visione filosofica del mondo, fu vissuta sostanzialmente come una teologia misterica, una via iniziatica alla perfezione.
Lo strumento conoscitivo che può mettere lâuomo a contatto con le modalità del manifestarsi del dio non appartiene alla sfera dellâempirico, ma sta oltre, deborda dai limiti dei sensi; esso appartiene, quindi, alla sfera dellâestatico e non a quella dellâestetico. âIntorno a natura e armonia, così stanno le cose: lâessere delle cose che è eterno, e la stessa natura primordiale richiedono una conoscenza divina e non umanaâ[31]. Lo stato di estasi mistica, che solo alcuni uomini riescono a vivere quando la loro anima si stacca dallâinvolucro mortale del corpo e sale verso le più alte sommità , è, anche dopo la morte (dopo la naturale separazione dal corpo), privilegio di pochi spiriti eletti: âNel cielo vi sono molte visioni di felicità e sentieri che lo attraversano, sui quali si aggira la stirpe dei beati ... Là appunto si presenta di fronte allâanima la tenzone e lâangoscia suprema. Le anime che si dicono immortali, difatti, ogni volta che sono giunte al vertice, trapassando al di fuori, si arrestano sulla superficie esterna del cielo e, condotte dal moto circolare, contemplano le cose dal di fuori ... Le altre anime ripiene di questo tormento se ne vanno senza essere iniziate alla visione di ciò che è e, allontanandosi, si cibano del cibo dellâopinione. Ma ciò onde deriva il grande tormento per riuscire a vedere la pianura della verità e scoprire dovâè, riguarda questo: il pascolo che si addice alla parte migliore dellâanima si trae appunto da quelle alte praterieâ[32]. Fin dallâinizio del suo poema Sulla Natura Parmenide di Elea, âche distolse la mente dallâinganno delle rappresentazioniâ[33], è messo in guardia dalla dea di allontanare i propri passi dalla via dellâapparenza e, quindi, di non cibarsi del cibo dellâopinione.
Il viaggio iniziatico che conduce lâuomo alla presenza dellâineffabile mistero divino ha come proprie condizioni essenziali lâessere puri e liberi dai vincoli corporei: â... senza essere sigillati nella tomba che appunto portiamo in giro e chiamiamo corpo, avvinti strettamente a lui come lâostrica al suo guscioâ[34], e lâesser genuinamente folli: âOnde appunto la follia, rivolgendosi alle purificazioni ed alle iniziazioni, liberò dal pericolo per il tempo presente e per quello futuro chi di essa partecipava, e procurò a chi era folle in modo autentico, ed era posseduto dal dio, la liberazione dai mali presentiâ[35]. Lâestasi - nel senso letterale del termine - è, come sâè detto, âlâuscir fuori da séâ, uno stato di autentica alienazione dove il posseduto dal dio ha la visione di quello che gli altri non vedono; lâestasi è, in ultima analisi, il modo per liberare il sovrappiù di conoscenza dallâazione inibitrice dei sensi. âDiversamente dal dio - dice Eraclito - lâuomo non possiede la conoscenza per sua caratteristica naturale (h'jqo")â[36]. Ma lâuomo ha una caratteristica naturale, che pur non essendo divina è demonica, ossia una qualità che lo potrebbe porre in posizione intermedia e intermediaria fra la terra e il cielo: âLâethos dellâuomo è un demone (h'jqo" ajnqrwvpwi daivmwn)â[37]. Ed è, appunto, a questa particolare qualità âdemonicaâ che bisogna porre attenzione per comprendere quel particolare tipo dâuomo che anela al contatto diretto con la Sapienza. Allorché Diotima di Mantinea, lâamica di terre lontane che iniziò Socrate alla scienza dâamore, si trova a definire Eros come demone, dice: âTale è la caratteristica di tutti gli esseri demonici: intermedi essi sono fra il Dio e gli esseri mortali ... Posti in mezzo fra lâuno e lâaltro mondo, colmano interamente lâimmenso vuoto che tali mondi separa e lâuniverso per tale mondo risulta unâunità complessa e coerente. Per opera di questi esseri superiori si svolge lâintera mantica, tutte le funzioni e le pratiche sacerdotali, i sacrifici, le iniziazioni, gli incantamenti, lâintera arte profetica e la magia. La divinità non ha diretto rapporto con il genere umano e soltanto attraverso i demoni ha relazioni con noi; ogni suo colloquio con gli uomini, così nella veglia come nel sonno, avviene per loro tramite. Lâuomo che ha conoscenza di queste cose è un uomo in rapporto con potenze superiori, un uomo demonicoâ[38]. Come Eros, il figlio di Povertà e di Espediente, questâuomo intermedio fra sapienza e ignoranza, è Filosofo: âAmante per tutta la vita di Sapienza, ossia filosofo egli è un potente incantatore, esperto di filtri e dellâuso della parola... non è né mortale né immortaleâ[39]. âAnima riarsa di sete - dice Eraclito - è la più sapiente ed è quella che eccelleâ[40].
A differenza degli dei che possiedono la sapienza per proprio ethos, il filosofo ne va costantemente alla ricerca; ma per lui la sapienza non è un qualcosa di mai raggiunto, che altrimenti non potrebbe essere oggetto del suo desiderio; al contrario, è come se alla sua psiche si affacciassero, ma solo per un inafferrabile istante, i frammenti scomposti del ricordo remoto di un tempo in cui Sophia aveva posto la propria dimora nelle stesse regioni dellâuomo.
Lâelpis o la speranza
Nelle Vite dei filosofi di Diogene Laertio viene citata una frase, attribuita ad Aristotele, certamente spuria, ma interessante per tutta la cultura antica: âLa speranza è un sogno fatto da svegliâ.
E tutti noi abbiamo letto Eraclito che proferiva âMorte è quanto vediamo da svegli e sogno quanto vediamo dormendoâ (14[a42]). Il âlucid dreamâ o sogno lucido in cui il sognatore ha coscienza del fatto di stare sognando assomiglia allâazione dellâimmaginazione nel sonno per cui Platone diceva âNulla vieta di credere che i discorsi che noi facciamo ora siano tenuti nel sogno e quando nel sogno crediamo di raccontare un sogno la somiglianza delle sensazioni nel sogno e nella veglia è addirittura meravigliosa ... Il tempo che noi dormiamo è uguale a quello che siamo desti e nellâuno e nellâaltro la nostra anima afferma che solo le opinioni che ha in quel momento presenti sono vere; sicché per un egual spazio di tempo noi diciamo che sono vere le une come le altre e lo sosteniamo con lo stesso vigore.â[41]
E lasciando la parola ad Omero: âOspite, i sogni sono vani, inspiegabili: / non tutti si avverano, purtroppo, per gli uomini. / Due son le porte dei sogni inconÂsistenti: / una ha i battenti di corno, l'altra d'avorio: / quelli che vengon fuori dal candido avorio, / avvolgon d'inganni la mente, parole vane portando; / quelli invece che escon fuori dal lucido corno, / verità li incorona, se un mortale li vedeâ. [42]
Lâuf isthmi mette a capo ad un upo isteme che non è lâepi isteme e men che meno una ex isteme, ma, come detto, un sapere âsotto stanteâ o âdi sostegnoâ: una hypostasis delle cose reali che si sperano (hlpizomÎnwn upÏstasi"). La fede è la âsostanzaâ delle cose in cui poniamo la fiducia, a cui diamo il nostro affidamento, che ci aspettiamo si avverino.
Eâ per questo che la lettera del teologo Joseph Ratzinger ci ha provocato queste riflessioni che vogliamo terminare con le sue parole: âLa fede è un habitus, cioè una costante disposizione dell'animo, grazie a cui la vita eterna prende inizio in noi e la ragione è portata a consentire a ciò che essa non vede. Il concetto di sostanza è quindi modificato nel senso che per la fede, in modo iniziale, potremmo dire in germe â quindi secondo la sostanza â sono già presenti in noi le cose che si sperano: il tutto, la vita vera. E proprio perché la cosa stessa è già presente, questa presenza di ciò che verrà crea anche certezza: questa «cosa» che deve venire non è ancora visibile nel mondo esterno (non «appare»), ma a causa del fatto che, come realtà iniziale e dinamica, la portiamo dentro di noi, nasce già ora una qualche percezione di essaâ.[43]
1 á¿Estin dá½² pίstiÏ á¼lpizomÎnwn á½pÏstasi" pracmάtwν á¼legcoÏ oá½ bleponÎmwν á¼n taá½»tá¿ gá½°r á¼marturήqhsan oá¼± presbá½teron Pá½·stei nooῦmen kathrtá½·sθai toá½ºÏ aἰῶnaÏ á¿¥á½µmati qeoῦ eá¼°Ï tὸ má½´ á¼k Ïainomá½³nwn tὸ bleponÎmoν gegoná½³nai
2T. W. Adorno, Minima Moralia, 46.
3Â Non vuol dire il cartesiano âbuonsensoâ e neppure lâinsieme organico delle certezze di fatto e di principio comuni ad ogni uomo e precedenti ogni riflessione critica, ma semplicemente le due funzioni sensibili aristoteliche che ho citato.
4 Platone, Teet; 189, e.
5 Ma non è ancora una suneidesis, ciò che accompagna lâeidos, la coscienza che attiene la sfera dellâinteriorità , concetto molto più tardo e di chiaro uso neoplatonico e cristiano.
6 evjcstasi" da ejxivsthmi (ex istemi), letteralmente âspostarsi da ciò che sta saldoâ.
7 Platone, Teeteto, 11. 155d.
8 Aristotele, Metafisica, I, 22, 948b sgg.
9 Per comprendere questa fondamentale articolazione del pensiero greco si confronti Platone, Menone, 97d - 98a, dove Socrate paragona l'insicurezza dell'opinione e l'instabilità del suo "sapere" alle statue di Dedalo (il mitico artigiano ateniese, reputato padre del nuovo stile, che aveva sostituito alla staticità delle statue stilobate la dinamica plasticità delle sculture che davano il senso del movimento): âQueste [le statue di Dedalo] quando non siano legate al piedistallo se la svignano e scappano; se sono legate invece restano ... Possedere una di queste opere sciolte non è di gran valore, esse sono come uno schiavo fuggitivo ... anche le rette opinioni, per tutto il tempo che rimangono in noi sono una gran bella cosa e producono ogni bene, ma purtroppo esse non restano a lungo, e se ne fuggono dalla mente dellâuomo, sicché non sono di grande pregio fino a che non le si leghi con dei vincoli causali ... dopo che sono state legate diventano in primo luogo conoscenza e, inoltre, diventano stabili. Per questa ragione la scienza [episteme] è di maggior pregio della retta opinione e ancora la conoscenza scientifica differisce dalla retta opinione proprio in virtù di quei legamiâ. Tali legami, che Platone chiama aijtiva" logismw/ (vincoli causali o meglio connessioni dimostrative), sono appunto ciò che il logos (la ragione) mette in atto per giustificare ciò che lâesperienza accerta, ma non spiega.
10 Hobbes T., De homine, X, 4-5 (cfr.: De cive, XVII, 4 e De corpore, XXV, 1), in Opera quae latine scripsit omnia, (ed) W. Moleswort, Londra 1849-45.
11 ibidem X, 5 (cfr.: Elements of Law 1, IV e Vl e Leviathan 1, IV, V).
12 ibidem.
13 Mersenne M., Harmonie universelle, Paris 1646-47 (esemplare a stampa della Biblioteca Nazionale V 2802, oppure Rés 17488), p. 8.
14 Tradurre con âla stessa medesima cosa sono la verità e lâutilità â è un errore da ginnasio, perché il termine ipsissimae res da un punto di vista filosofico vuol dire âessenzaâ o âformaâ e non âla stessa cosaâ.
15 Les Oeuvres de B. Palissy publiées d'après les textes originaux avec une notice historique et bibliographique, par A. France, Paris, 1880. Fra cui: Discours admirables, Paris, 1580; Recette veritable par laquelle tous les hommes de France pourront apprendre à multiplier leurs thrésors. Item ceux qui n'ont jamais eu cognoissance des lettres pourront apprendre une philosophie nécessaire tous les habitants dr la terre, La Rochelle, 1554. Si prenda la seguente citazione: âMediante la pratica io provo esser false in più punti le teorie di molti filosofi, anche i più antichi e rinomati. In meno di due ore ciascuno potrà rendersene conto purché si prenda la pena di venire nel mio laboratorio. In esso si possono vedere cose mirabili (messe a prova e testimonianza dei miei scritti), collocate in ordine e con delle scritture al di sotto affinché ciascuno possa istruirsi da solo. Ti posso assicurare, o lettore, che, sui fatti contenuti in questo libro, imparerai più filosofia naturale di quanta non ne impareresti in cinquantâanni leggendo le teorie e le opinioni dei filosofi antichiâ, p. 166.
16 Cartesio R., Cogitationes privatae, in Oeuvres inédites des Descartes (ed) Foncher de Careil, Parigi 1859-60. Da parte nostra ci riferiamo a: Oeuvres de Descartes, (ed) Adam-Tannery, Paris 1897-1914, vol. X, pp. 214 e segg. (dâora in poi A.-T.), cfr. E. Garin, Cartesio, Opere, Bari, 1967.
17 Pascal B., Pensées et opuscules, (ed) L. Brunschvicg, Parigi 1914-17, fr. 580.
18 ibidem fr. 448.
19 ibidem fr. 794.
20 ibidem fr. 547 et 79.
21 Gassendi P., Opera omnia, Lyon 1658, 111, 414.
22 Mersenne M., Les Questions Theologiques, physiques et mathematiques⦠Paris, 1644. Ques. Th. pp. 229-40.
23 M. Mersenne, La Vérité des Sciences, contre les sceptiques ou Pyrrhoniens .., Paris, 1625, p. 20 Ver. Sc.
24 Pascal B., fr. 252 loc. cit.
25 Mersenne M., F. Marini Mersenni Ordinis Minimorum S. Francisci de Paula Quaestiones celeberrimae in Genesimi, cum accurata textus explicatione..., Paris, 1624. Ques. in Gen., col. 606, 765, 766.
26 Malpighi M., Risposta del dott. Marcello Malpighi alla lettera intitolata "De recentiorum medicorum studio dissertatio, epistularis ad amicum", in Luigi Belloni, Malpighi, Torino, 1967 (dâora in poi la citeremo col titolo Sugli studi dei medici moderni).
27 ejmpeiriva (empeiria, esperienza) ed evjmpeiro" (empeiros, esperto) derivano da ejn pei'ra (entro lâesperienza) così come da ejn pevrajv" (entro i limiti). Si noti che lo stesso termine apeiron sta nello stesso tempo per designare sia lâinfinito illimitato che il non sperimentabile, dove lâuno è conseguenza logica dellâaltro.
28 aijvsqhsi" (aistesis, percezione sensoriale) da cui il termine âesteticaâ, usato per denotare la conoscenza sensibile.
29 ajlhvqeia (aletheia, verità ) deriva, come è noto, da a - lanqavnw (a - lanthano, non nascondo, rendo palese, quindi svelo). La complessa articolazione semantica della verità come disvelamento e rivelazione si istalla nella presa di coscienza che il mettere a nudo tutta la verità offusca la mente, così come quando gli occhi sono colpiti da una luce abbacinante, per cui è necessario schermare la verità , ri-velandola, ossia nascondendola di nuovo onde proteggerla.
30 Il termine musica non voleva dire una determinata techne, bensì tutte le arti delle Muse e si riferiva a qualcosa che era di suo "compiuto in perfezione" e "dotato di bellezza".
31 Filolao, DK 44 B 6 et Stobeo, Eclogae, I, 21 7 d.
32 Platone, Fedro, 247 a-c e 248 b-c.
33 Platone, Timone, fr. 44 DK.
34 Platone, Fedro, 250 c.
35 Platone, Fedro, 244-e e 245 b. Si noti che Platone mette in chiaro il legame fra lâessere folli in modo autentico e lâessere posseduti dal dio.
36 Eraclito, DK I 168 et Origene, Contro Celso, 6, 12.
37 Eraclito, 22 B 119 BK et Stobeo, Florilegio, 4,40,24.
38 Platone, Convito, 24.
39 ibidem.
40 Eraclito DK 1 177 et Stobeo, Florilegio, 4, 5, 8.
41 Platone, Teeteto, 158 c â d.
42 Omero, Odissea, XIX, 560-567 tr, it. di Rosa Calzecchi Onesti
43 Lettera Enciclica Spe Salvi del Sommo Pontefice, Benedetto XVI
Di Paolo Aldo Rossi in Airesis, nella sezione Il Giardino dei Magi, sono ospitati i seguenti contributi:
- Paolo Aldo Rossi, Marsilio Ficino: dalla Cristianizzazione della Magia alla Magicizzazione del Cristianesimo
- Paolo Aldo Rossi, Ut Pictura Poësis. il gioco dei Tarocchi fra Ermetismo e Teatro della Memoria
- Paolo Aldo Rossi, L'utopia rosacrociana nell'età di Bacone e di Cartesio
Nella sezione Le Stagioni della Follia, è ospitata la serie completa di interventi da titolo Horror et Amor Diabolicus, dedicata al fenomeno della stregoneria tra medioevo e rinascimento:
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 1. Le fantasie psicopatiche delle streghe
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 2. L'unguento per volare al sabba
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 4. I tempi della tolleranza
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 4. Il prologo della repressione
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 5. L'inizio del dramma persecutorio
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 6. Il Malleus maleficarum
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 7. Il rapporto etnico-culturale
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 8. I tempi negati alla speranza
- Paolo Aldo Rossi, Horror et amor diabolicus / 9. Il tema della tortura
Nella sezione Recensioni sono inoltre recensiti i seguenti testi, scritti o curati da Paolo Aldo Rossi: